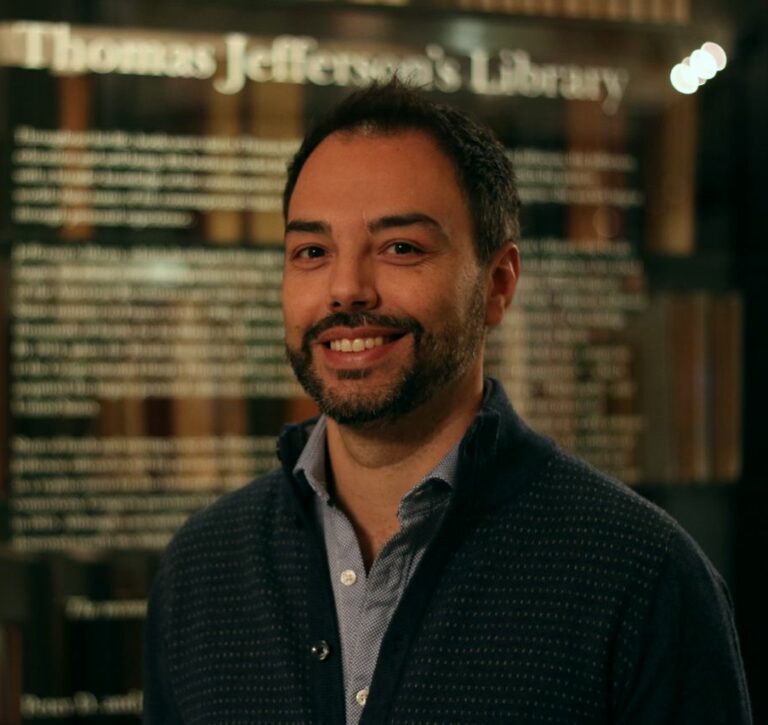È al centro dei discorsi, degli entusiasmi (a parte il caffè, sembra che sia in grado di fare qualunque cosa, e spesso meglio di noi), dei timori di deviazioni maligne o semplicemente della preoccupazione che presto ci renda disoccupati. Eppure, il funzionamento dell’intelligenza artificiale, il contesto di ricerca da cui emerge, le opportunità che offre e i rischi reali che rappresenta rimangono oscuri per la maggior parte di noi. Alla ricerca di risposte ai dubbi più comuni, abbiamo esplorato il tema con Davide Bacciu, professore ordinario in machine learning all’Università di Pisa, e responsabile del Pervasive Artificial Intelligence Laboratory (PAILab).
Oggi si parla moltissimo e in tantissimi ambiti di intelligenza artificiale. Come esperto del settore, qual è la domanda più curiosa o frequente che ti senti rivolgere da amici e parenti?
Fino a non molto tempo fa era: “ma cosa fai esattamente?”, dato che nominavo le reti neurali o l’intelligenza artificiale, ma nessuno capiva di cosa mi occupassi in concreto. Secondo me tuttora non lo capiscono in molti, però adesso la domanda classica è: «l’intelligenza artificiale ci ucciderà tutti?». E la seconda: «mi ruberà il lavoro?». Essendo un ottimista, la risposta che do alla prima domanda è che sicuramente l’intelligenza artificiale disponibile ora non ci può fare granché di male: i danni li fanno gli uomini, non le macchine.
Alla seconda rispondo invece che, a seconda del lavoro che fai, sì. Il problema ce lo dobbiamo porre: l’IA è una tecnologia trasformativa, come tutte. Se di lavoro un tempo facevi il cocchiere, quando hanno inventato i motori ti saresti trovato disoccupato. Bisogna porsi il problema, cambiare magari il modo in cui concepiamo la società, l’economia e il ruolo del lavoro all’interno della società… ma questo è un altro discorso.
Ma i timori espressi dalle persone a proposito della perdita del lavoro sono realistici oppure no?
Il problema riguarda tutte le professioni. Se non sei a un certo livello per cui le tue competenze “umane” sono insostituibili, è probabile che verrai sostituito da qualcosa che fa il tuo stesso lavoro (o qualcosa che viene percepito come tale) a un costo inferiore. C’è poco da indorare la pillola… Il problema non è la tecnologia, il problema è che ci siamo scelti un sistema economico-sociale che non può resistere al cambiamento rapido imposto dalla tecnologia moderna e quindi dobbiamo ripensarlo, più che preoccuparci di fermare una tecnologia. Della tecnologia, una volta che è stata ingegnerizzata, possiamo però regolare l’uso. C’è anche da dire che nessuno ci obbliga a vivere in questo sistema.
Qual è la differenza sostanziale tra ciò che chiamavamo Machine Learning e l’IA contemporanea?
Spesso questi termini vengono usati erroneamente quasi come sinonimi. In realtà, “intelligenza “artificiale è un termine che definisce una disciplina estremamente ampia, mentre il “machine learning” è uno dei paradigmi che sta dentro l’intelligenza artificiale. Quella che al momento, nella volgata comune, viene associata al termine intelligenza artificiale è addirittura una sottoarea del machine learning legata ai modelli generativi del linguaggio. Se oggi parlo di intelligenza artificiale, tutti pensano a ChatGPT o affini.
Riassumendo, l’intelligenza artificiale è tutta l’area, mentre il machine learning è una sottoarea dell’intelligenza artificiale che cerca di perseguire come scopo ultimo la creazione di modelli computazionali informatici in grado di svolgere compiti che siano indistinguibili da quelli che svolgerebbe un essere umano. Non c’è una migliore definizione di questa, perché per averne una avremmo bisogno di una migliore definizione di “intelligenza”, che è difficilissima da dare.
E a che punto è arrivato oggi il machine learning?
Altri approcci che prima erano prevalenti nel mondo dell’intelligenza artificiale cercavano di codificare i meccanismi di ragionamento e della conoscenza dell’uomo con dei modelli formali e poi lasciare funzionare questo “motore di ragionamento” come farebbe un umano. Il machine learning, che al momento è il paradigma principale, cerca di costruire dei modelli in cui il comportamento intelligente viene appreso totalmente dall’esperienza, ovvero dai dati, in maniera automatica. Prima si cercava di farlo in maniera molto specializzata, costruendo i dati, pulendoli e prepararandoli per darli in pasto a modelli più semplici. Questo perché non avevamo dati. Adesso, il Deep Learning ci permette di prendere dati come sono e usarli direttamente per apprendere dall’esperienza. Siamo riusciti a ingegnerizzare tutta la fase di estrazione di informazioni da dati che sono estremamente sporchi, rumorosi, e complessi. Questo è stato il vero salto di specie.
Qual è stato il percorso che ti ha portato a ricoprire il ruolo che hai adesso?
È stato piuttosto tortuoso. Il mio dottorato si è concluso in maniera drammatica: la mia supervisor è morta mentre scrivevo la tesi, cosa che mi ha lasciato addolorato e spossato. Ho dovuto ragionare un po’ per decidere se volevo fare effettivamente questo lavoro, dato che non ero nelle condizioni ideali. Tra l’altro mi ostinavo a lavorare alle reti neurali e all’intelligenza artificiale, che all’epoca erano considerati un suicidio professionale da chi faceva computer science.
È stato però alla fine un buon investimento. Sono stato anche fortunato perché la persona da cui ero andato a fare un periodo di visiting all’estero, da studente di dottorato, mi ha dato un’opportunità: ha trovato un finanziamento grazie al quale ho fatto prima alcuni mesi da lui a Liverpool e poi ho avuto una borsa di postdoc. I soldi non erano abbastanza per finanziare un postdoc negli UK, ma bastavano per l’Italia, e così ho avuto una posizione postdoc cofinanziata dall’Università di Pisa e dall’Università di Manchester. Ho iniziato a collaborare a Pisa con le poche persone che c’erano all’epoca, a vincere uno dopo l’altro alcuni progetti e mi sono reso presto abbastanza indipendente. Questo mi ha permesso, da zero, di costruire un piccolo gruppo di ricerca con i primi quattro cinque dottorandi, che ora è diventato un gruppo di una cinquantina di persone. Ha giocato un grosso ruolo la fortuna, dato che è poi esploso anche tutto il mondo dell’intelligenza artificiale assieme a un interesse sempre crescente da parte degli studenti.
Quanto ritieni sia importante la ricerca? E in particolare nel tuo campo?
Se non la ritenessi importante avrei scelto di fare un altro lavoro, ovviamente. Se non hai persone che hanno la spinta, la voglia e la capacità di affrontare l’ignoto, l’umanità non va avanti nel suo progresso culturale, tecnologico e scientifico. Poi è vero che la ricerca si può fare in tanti modi. C’è chi riesce a fare ricerca che fa fare salti di decenni all’umanità, perché hanno le capacità e perché arrivano nel momento giusto, e ci sono le persone che sono in grado di spostare un granellino. Ma anche i granellini contano. L’intelligenza artificiale è uno di questi esempi. Le reti neurali, come dicevo prima, sono state per tantissimo tempo in un binario secondario. Poi, vari ricercatori si sono impegnati, nonostante questo, a lavorare al granellino, a farlo diventare prima una palla di neve e poi una valanga… Se gli scienziati avessero smesso 60 o 70 anni fa di occuparsi di reti neurali, oggi non saremmo dove siamo. La ricerca si fa anche in diversi contesti: nelle industrie, nell’accademia… ed è importante continuare a tenerli vivi tutti, pubblici e privati. La ricerca delle aziende non sarebbe possibile se non ci fosse stata prima quella degli istituti pubblici. E adesso continuano a servire gli istituti di ricerca pubblici, perché servono le persone che facciano ricerca non solo sull’IA ma anche su tante altri temi che magari fra vent’anni verranno riusate dalla ricerca industriale. Quindi la ricerca è importante, sì, ed è importante tutta la ricerca. Mi accaloro quando racconto queste cose!
Ci sono stati momenti in cui hai pensato di lasciare la ricerca o il mondo accademico?
Costantemente. È successo più volte, ma credo sia normale. Questo è un lavoro estremamente stressante, e spesso frustrante. Mi spiego: si passa la maggior parte del tempo a lavorare a cose che non funzionano. Solo ogni tanto funzionano, e quella volta che capita devi far durare la soddisfazione per il lungo tempo in cui ricominci a fare cose che di nuovo non funzionano… È assolutamente normale mettersi in discussione, ma si tratta di un lavoro che se non lo “scegli” quotidianamente ti mangia un po’ l’energia e la testa. È anche importante trovare delle persone che ti danno i consigli giusti al momento giusto. Io a un certo punto, finito il dottorato, mi sono detto “basta, vado a lavorare per un’azienda di consulenza” che all’epoca era come dire “vado a lavorare per guadagnare tanto”. Arrivato al colloquio di selezione, il responsabile mi ha chiesto: “dottor Bacciu, è sicuro di voler fare questo lavoro? Perché quando parla della ricerca che faceva le brillano gli occhi…”. Tornando a casa ho pensato: “forse devo dare alla ricerca un’altra opportunità”. Se al colloquio non mi avessero fatto quella domanda forse non sarei qui ora.
Roberto Pizziol