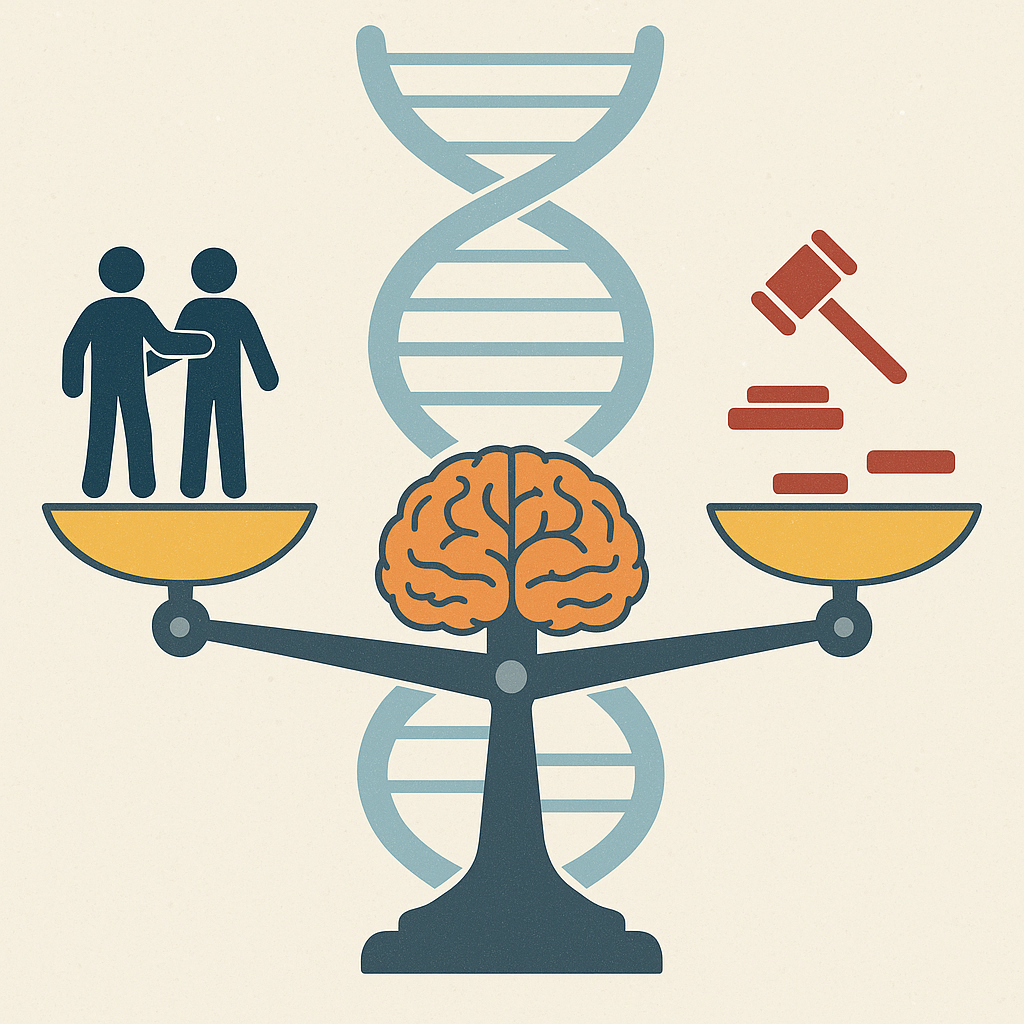
Anche se i tempi che viviamo ci farebbero pensare non sia così, è una regola generale che gli esseri umani sono portati a cooperare, ovvero a farsi carico di un costo personale che non li avvantaggia direttamente ma avvantaggia un’altra persona, oppure la collettività. Perché questo avvenga rimane un mistero dal punto di vista scientifico, visto che l’altruismo è considerato un controsenso in base all’interpretazione più tradizionale (e superata) della teoria dell’evoluzione.
Dietro a queste dinamiche e comportamenti sociali, come ormai molti studi hanno appurato, c’è anche la biologia: particolari configurazioni genetiche sono associate a comportamenti più o meno altruisti oppure aggressivi e individualisti. Un gruppo di scienziati della Scuola IMT e delle Università di Pisa e di Firenze ha condotto uno studio, appena pubblicato sulla rivista Scientific Reports, per esplorare più a fondo il ruolo della genetica nei comportamenti prosociali, e dunque altruistici.
Lo studio è stato condotto nell’ambito della teoria dei giochi, che offre la possibilità di progettare esperimenti comportamentali utilizzando test codificati in cui i partecipanti devono fare delle scelte, per esempio tra l’interesse personale e il “bene” comune. Secondo le teorie economiche classiche, le persone dovrebbero essere naturalmente portate a comportarsi in modo individualista, massimizzando il proprio guadagno a spese degli altri. Tuttavia, esperimenti su larga scala hanno mostrato che questo non è il comportamento più comune: gli esseri umani in realtà molto spesso cooperano, che sia per empatia verso gli altri, perché si conformano a norme sociali che lo richiedono, o semplicemente perché si aspettano un comportamento reciproco in caso di bisogno.
I ricercatori hanno allestito l’esperimento reclutando 99 volontari , che hanno giocato online al cosiddetto “gioco dei beni pubblici”. Si tratta di una situazione sperimentale che rappresenta un conflitto tra il proprio interesse personale e quello comune. Il contesto del gioco è simile a quello in cui si svolgono molte situazioni della vita quotidiana. Per esempio, un gruppo di vicini deve raccogliere soldi per ripulire un parco pubblico: se tutti partecipano, il parco migliora e il beneficio è di tutti; se uno non paga la sua parte ma gode comunque del parco, gli altri potrebbero decidere di sanzionarlo.
Nella simulazione online, gruppi anonimi di quattro persone chiamati a giocare ricevevano 10 punti a testa: ogni giocatore poteva tenerli o decidere di versarli in un fondo comune che veniva poi raddoppiato e diviso equamente. Se tutti contribuiscono, il guadagno di gruppo è massimo (20 punti a testa); tuttavia, la convenienza per una singola persona è di non dare alcun contributo, e beneficiare comunque del fondo comune. Nella simulazione, dopo aver fatto la sua scelta, chi partecipava doveva anche indovinare le intenzioni degli altri, con quanto pensava avrebbero contribuito o non contribuito gli altri.
Parallelamente al gioco, ai partecipanti è stato prelevato un campione di saliva per estrarne il DNA. In laboratorio sono state analizzate otto varianti genetiche legate a serotonina e dopamina, due neurotrasmettitori che giocano un ruolo in vari processi cognitivi e affettivi, dalla regolazione dell’umore, al piacere alla motivazione. Si sa per esempio che ridurre artificialmente la serotonina (ad esempio con una dieta priva di triptofano, aminoacido presente in molte proteine, e che ne è alla base) porta le persone a cooperare meno. Anche un aumento della dopamina nel cervello è associato a un calo delle scelte altruistiche. L’obiettivo era vedere se i diversi genotipi dei partecipanti erano associati a stili di cooperazione differenti durante il gioco. E questo è in effetti quello che lo studio ha mostrato.
“In sintesi”, spiega Erica Ordali, ricercatrice alla Scuola IMT e prima autrice del lavoro “i risultati ci mostrano che specifiche varianti genetiche sembrano influenzare in modo significativo non solo il comportamento, ma anche le aspettative sul comportamento degli altri. Ad esempio, chi possiede una certa versione del gene che rende la serotonina più bassa tende a contribuire poco al fondo comune, e a immaginare che anche gli altri faranno lo stesso. I soggetti con il gene che ‘aumenta’ la serotonina sembrano invece avere più fiducia negli altri, ed essere più ottimisti sulle loro intenzioni. Allo stesso modo, un altro genotipo ancora, che rende la dopamina cerebrale più persistente, corrisponde a un atteggiamento ‘difensivo’, che dà per scontato i contributi altrui saranno bassi”.
In definitiva, lo studio mette in luce un “filtro genetico” che modella le nostre aspettative sugli altri, se siamo più inclini a sospettare o condividere, e il modo in cui decidiamo di aiutare o punire. Conoscere i meccanismi genetici alla base della cooperazione potrebbe anche aiutare a capire come promuovere comportamenti altruistici o a gestire quelli egoisti nelle società o anche a risolvere dilemmi sociali reali, dal rispetto delle leggi al cambiamento climatico
Chiara Palmerini